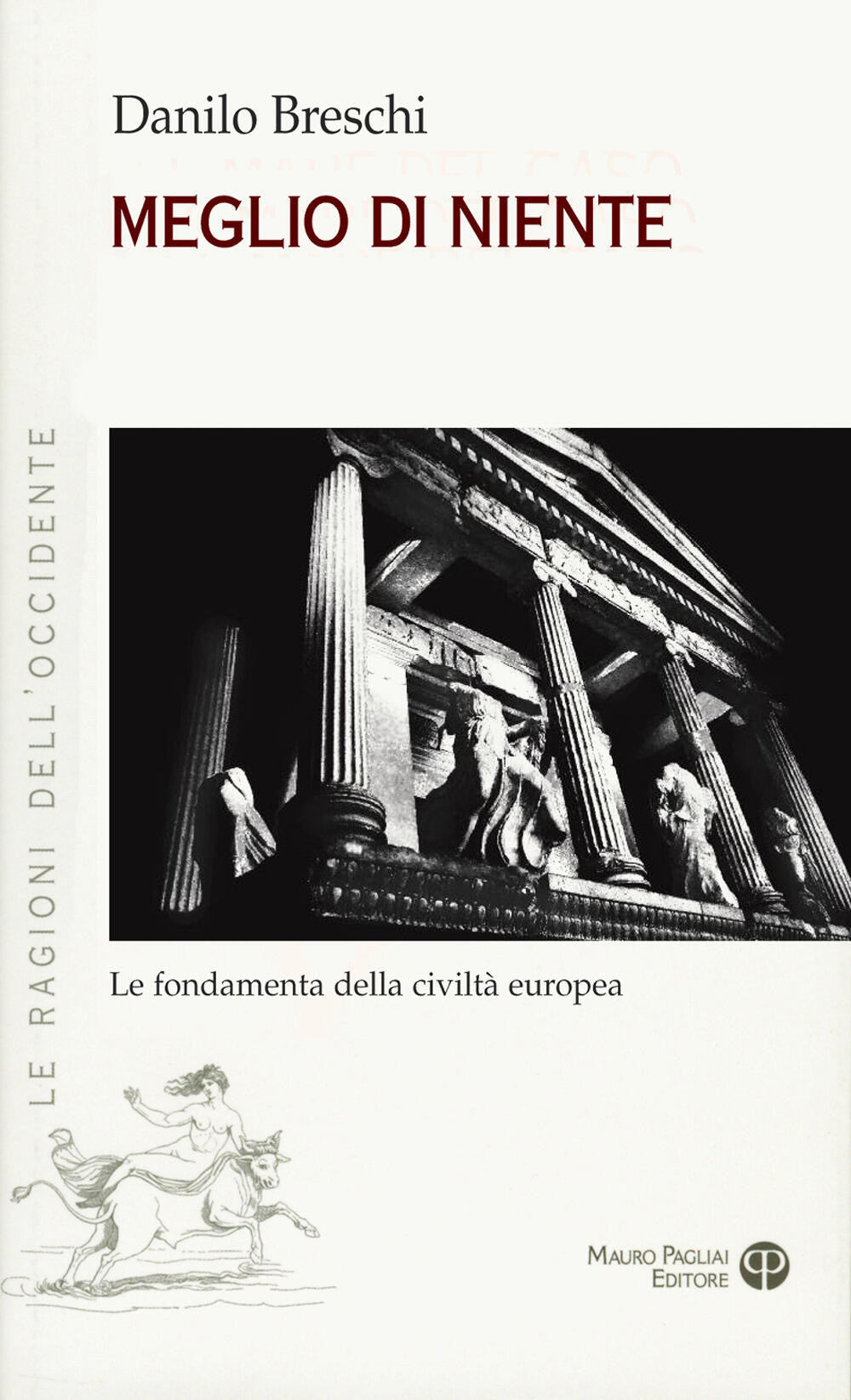di Luca Demontis
(Scuola Internazionale di Alti Studi – Fondazione Collegio San Carlo di Modena)
Recensione a: Danilo Breschi, Meglio di niente le fondamenta della civiltà europea, Mauro Pagliai Editore, Firenze 2017, pp. 195, € 12.
Meglio di niente raccoglie le riflessioni di un sincero liberale classico, frequentatore assiduo delle opere di Montesquieu e Tocqueville, per cui i pilastri della società aperta non sono quelli che sostengono l’ordine spontaneo del mercato, ma gli usi e i sentimenti sedimentati nella storia, nella politica, nella religione, nell’educazione. Breschi è un autore con il gusto del bel periodare e della prosa rifinita, consapevole che la cura stilistica nella scrittura è la prima via di liberazione dalla tirannia dei linguaggi del presente: «una ripulitura lessicale e concettuale, ecco di cosa avremmo bisogno» (p. 86). Il suo libro non si perde nei gerghi e nelle mode di una produzione accademica sempre più abbondante e asettica, incoraggiando piuttosto un’equilibrata riflessione sui presupposti più profondi e generali della nostra convivenza.
Fin dalle prime pagine, echeggia come basso continuo un richiamo di sapore crociano alla libertà come «eterna formatrice della storia, soggetto stesso di ogni storia», e una conseguente, ferma opposizione alle ideologie del declino, perché l’Occidente sopravvive al peso della sua storia solo se, saldo nella consapevolezza delle sue tradizioni, da queste riparte per acquisire nuovo slancio. Tradizioni imperfette e fallibili come tutto quanto origina dal «legno storto dell’umanità», ma che sono appunto indefinitamente «meglio di niente» nella loro capacità di assicurare dignità, sicurezza e diritti ai cittadini delle democrazie europee contemporanee. Garanzie delle quali tanto più avvertiamo l’importanza quanto più, come oggi, sentiamo il rischio di erosione a cui sono soggette.
Il motore politico della modernità europea è il pluralismo istituzionale, ossia la possibilità di incanalare attraverso le istituzioni il conflitto tra valori e interessi contrastanti. Questo è stato reso possibile dalla fioritura di tanti e diversi centri di influenza sulla pubblica piazza: la Chiesa, il Comune, il Mercato, i Palazzi signorili, hanno per secoli elaborato nel conflitto e nella ricerca di compromesso – che, come ricorda Breschi, è necessariamente al cuore di ogni convivenza sociale – nuove forme di vita e nuovi valori. Nella continua tensione tra popoli e tra nazioni, la modernità politica europea è un progetto instabile e incompiuto, e il sogno di un’Unione Europea nasce con l’intento di portare a sintesi le forze che tendono costantemente a disgregarla conducendola alla stasis, condizione così comune in epoca moderna e contemporanea.
In quanto strumento per risolvere il conflitto tra valori in forme non violente, le procedure democratiche esigono come presupposti inalienabili la tolleranza e il pluralismo. Sono necessari caratteri «democratici», al tempo stesso fermi e saldi quanto inclini alla mitezza, al compromesso, al negoziato. Il vero limite intrinseco delle società contemporanee è che si tratta di valori che non scaldano i cuori: «non essere amate. Questo è il pericolo maggiore per le nostre democrazie» (p. 97).
Come sottolinea Breschi, la democrazia presuppone un’apertura pluralista che non coincide affatto con il multiculturalismo. Riprendendo con Nicola Matteucci un’influente categorizzazione rawlsiana, è fondamentale distinguere il «pluralismo ragionevole» dal «pluralismo in quanto tale» (p. 92). Il primo considera un valore il continuo confronto tra culture diverse e necessita dunque di un pensiero forte, e tutt’altro che relativista, che possa ergersi come architettura comune della convivenza; il secondo, quello caro alla vulgata multiculturalista, negando ogni possibilità di valutazione assiologica delle diverse culture, rischia costantemente di porre sullo stesso piano sia i «pluralisti ragionevoli» che i fanatici.
Qualunque periodizzazione si accetti per quanto riguarda la nascita e lo sviluppo del pluralismo dei valori – di cui si possono rintracciare le origini nello scetticismo rinascimentale, nella reazione alle guerre di religione, nella separazione tra stato e chiesa, nell’illuminismo francese o scozzese, o, ancora, nell’età romantica -, non c’è dubbio che la modernità europea abbia giocato un ruolo fondante nella definizione delle sue categorie.
Una democrazia liberale si regge dunque su un ethos condiviso, sulla simmetria di diritti e doveri, sulla coscienza delle responsabilità del cittadino e sull’accountability delle classi dirigenti, ovvero sulla capacità argomentativa di rendere conto delle azioni e delle scelte compiute. L’ideale di democrazia occidentale contemporanea deriva dal matrimonio indissolubile, ma pur sempre di convenienza, con il liberalismo: due tradizioni a lungo quasi incompatibili, che il mondo occidentale nel secondo dopoguerra è riuscito a congiungere felicemente.
Il liberalismo caldeggiato da Breschi non è quindi apertura indiscriminata al mercato, perché consapevole del peso di consuetudini che, se non tenute in considerazione, generano nuove aristocrazie e nuovi conglomerati di poteri economici e familiari, neutralizzando ogni democratica eguaglianza delle opportunità. Allo stesso tempo, però, sarebbe puro autolesionismo non ricordare che il tanto vituperato capitalismo consumistico ha generato un benessere di massa che, se «non ha equivalso alla pubblica felicità, ne è stato però la maggiore e migliore approssimazione storicamente sperimentata» (p. 123).
Per Breschi la crisi economica è innanzitutto crisi morale, politica ed esistenziale, pigro adagiamento sull’esistente, incapacità di pensare diversamente, di avvertire lo stimolo all’innovazione e al rischio, di capovolgere il peso del fallimento in impulso al miglioramento. Deriva innanzi tutto dal cinismo stanco e rassegnato di una popolazione sempre più «senile», in senso non tanto anagrafico quanto «sveviano» di chi ha smesso di desiderare, dall’arrendersi agli imperativi dell’eterno presente, dall’incapacità di scavare nelle profondità della storia e di gettare uno sguardo al di là della nostra epoca per concepire, riproporre o reinventare forme di vita più propizie alla fioritura dell’umano. Breschi sa che nessuno innovazione è creazione ex nihilo, e che solo la consapevolezza delle esperienze di chi ci ha preceduto permette di accendere la facoltà immaginativa.
Nello specifico, Breschi dedica molte pagine al male italiano del familismo amorale, all’irrefrenabile tendenza al tribalismo, all’incapacità di sottomettersi alla sovranità di norme astratte e generali che, quanto più appaiono lontane dagli interessi immediati e concreti del proprio clan, tanto più garantiscono libertà e diritti, rimpiazzando l’arbitrario governo degli uomini con le certezze offerte dal governo delle leggi. C’è in Italia un bisogno di anarchia e un ribellismo piccolo borghese, venati di insubordinazione verso gli obblighi – innanzi tutto fiscali – imposti dallo Stato centrale, che ha sempre impedito la maturazione di posizioni politiche ispirate a una calma forza conservatrice.
Vige l’abitudine a un rapporto servile con l’autorità, proprio di chi traffica per ottenere un potere che non è mai facoltà effettiva di cambiare le cose, vincolato com’è al gioco incrociato dei veti e dei favori. «In Italia nessuno comanda, ma tutti si impongono», nella spietata massima prezzoliniana citata da Breschi, attuale oggi esattamente quanto nel 1921. Un’Italia dominata dal potere invisibile dei burocrati e dei grand commis, che devono la propria sopravvivenza alla capacità di formulare codici e leggi incomprensibili ai non addetti ai lavori; prona a un senso comune incline alla formazione di consorterie criminali; esposta costantemente al rischio di cessione indiscriminata di risorse pubbliche per fini privatissimi.
Un liberale classico non può che evidenziare i pericoli che emergono quando il liberalismo politico viene egemonizzato e quasi assorbito dal liberalismo economico. Breschi ricorda dunque come le diseguaglianze economiche provochino la dissoluzione della classe media. La miseria accende le passioni violente; al contrario, la democrazia liberale richiede un atteggiamento riflessivo condiviso, un capitale sociale di fiducia reciproca e una certa tensione repubblicana, la certezza della proprietà e l’adeguatezza di quest’ultima a uno status decente. Mentre tali trame si dissolvevano durante la crisi, non si è estinta «la domanda di legame sociale, di adesione a qualcosa che ci protegga e accompagni per meglio ancorarci di fronte a una globalizzazione che tende a sradicare tutto» (p. 130).
È iniziato l’infinito «decennio dell’Io», annunciato da Tom Wolfe nel 1976 e tutt’altro che concluso. Ma mentre le appartenenze comunitarie venivano date per morte dall’egemonia delle scienze sociali, liquidate dalle teorie della «scelta razionale» di sociologi ed economisti, la loro fiamma ha continuato a bruciare sotto la cenere, ed è tornata sotto forma di populismo, ora che il «Popolo», entità fluida e inafferrabile, sembra essere l’unico fulcro aggregante rimasto. Scompaiono i partiti, le rappresentanze sociali, le associazioni e i corpi intermedi, mentre i bisogni e gli interessi non sembrano più potersi coagulare intorno a obiettivi comuni. Senza strategie di lungo respiro, la politica contemporanea si fa risposta quotidiana ai bisogni, divenendo brodo di coltura ideale per la propagazione dei populismi.
Riadattando una metafora usata da Isaiah Berlin per descrivere il nazionalismo, il populismo è come un ramoscello incurvato: nasce dall’impressione di una pressione e di una umiliazione subita dal popolo per mano delle élites, a cui si oppone, nel momento liberatorio delle elezioni, un colpo di frusta opposto, inconoscibile (mediante sondaggi) e incontrollabile. Nell’ascesa dei populismi contemporanei è in gioco un tema politico più ampio, ovvero la promessa non mantenuta dell’autogoverno per responsabilizzare il popolo: all’espansione dei diritti, dell’istruzione, degli spazi di libertà negativa, si riteneva, farà seguito una sempre maggiore responsabilità condivisa. Gli effetti sono stati opposti. Dapprima nella socialdemocrazia, in cui cittadini abituati a vedere tutti i bisogni soddisfatti dalla culla alla tomba per opera del welfare state hanno consumato gran parte delle risorse economiche e ambientali disponibili, incuranti delle generazioni future. Poi nella democrazia di mercato, in cui il consumatore, in quanto sovrano, diviene un mero stakeholder privo di ogni senso del dovere civico e di responsabilità sociale. Da ultimo nella democrazia elettronica, dove la rabbia e la frustrazione rispetto alla politica appaiono strutturali. Nelle forme fittizie di socievolezza che caratterizzano la nostra «ribellione delle masse 2.0» si incanala l’insoddisfazione per l’incapacità di apportare un contributo effettivo allo spazio concreto della polis. Il tipico «cittadino elettronico», non disponendo di strumenti effettivi per partecipare alla strutturazione delle procedure democratiche, sfoga il conseguente senso di inettitudine mediante post furibondi o scelte radicali alle elezioni. Egocentrico e narcisistico, è abituato a soddisfare immediatamente ogni bisogno con un clic, incapace di discernere l’importanza dei tempi lunghi della storia. Mentre la politica è lo spazio della mediazione, i suoi bisogni divengono sempre più immediati.
Se la promessa dell’autogoverno del popolo non si è realizzata, un’altra promessa non mantenuta della democrazia rappresentativa è la formazione di una classe dirigente. La democrazia rappresentativa risponde alla necessità di disporre di persone educate alla mediazione politica, alla complessità amministrativa e alla gestione del conflitto. Come ideale, la democrazia rappresentativa vuole coltivare una élite capace di allontanarsi dalla immediatezza dei bisogni quotidiani, al fine di elaborare piani e strategie di lungo respiro.
In breve, la democrazia rappresentativa delle origini prometteva di formare una borghesia nel senso alto inteso, tra gli altri, da Thomas Mann, capace da un lato di stabilire criteri culturali, estetici e morali per elevare i gusti delle masse democratiche, dall’altro di farsi interprete consapevole di una tradizione, di incarnare democraticamente uno spirito repubblicano, di ispirare un principio d’ordine.
Una simile élite dovrebbe ovviamente rivendicare l’autorevolezza necessaria per proporre ideali e principi regolativi, invece di ostentare indulgenza paternalistica per un «Popolo» mitizzato del quale, quanto più si assecondano i vizi, tanto più si disprezza la capacità di miglioramento e di elevazione. Quando così non avviene, le conseguenze sono amare, e le istituzioni formative divengono grandi sanatori in cui docenti, psicologi e pseudo-esperti a vario titolo insegnano ad allievi sempre più «sdraiati» che il conflitto tra valori non è il sale dell’esistenza, ma un disagio da curare in forme terapeutiche. I passaggi da uno stadio all’altro della crescita possono essere dolorosi ma, senza disponibilità al sacrificio, schiere di eterni adolescenti attraverseranno la vita senza mai elaborare il principio di realtà necessario per giungere all’età adulta.
Al contrario, per un liberale l’educazione consiste nell’invitare l’uomo a coltivare le proprie facoltà e ad averne cura, in accordo con la propria natura. Contrariamente all’opinione diffusa tra i paladini dell’informazione continua, non tutte le fonti educative sono pari, ma esistono punti fermi, che sono le opere classiche del pensiero, della letteratura e dell’arte. L’educazione liberale consiste, si direbbe con Leo Strauss, nel confronto con le riflessioni maturate dai grandi spiriti di fronte agli eterni dilemmi dell’esistenza. Dal momento che le loro risposte sono state tutt’altro che concordi, non sarà mai possibile offrire la dottrina compiuta e definitiva a cui aspirano gli odierni creatori di slogan. I classici, ribadisce Breschi, restituiscono un senso all’idea originaria di cittadinanza democratica, riportando davanti agli occhi modelli di eccellenza e di grandezza d’animo, così come di equilibrio e di senso della misura. È un confronto che genera umiltà, ma anche la fiducia in se stessi necessaria per elevarsi dal rumore, dalla frenesia, dalla pigra accettazione dell’opinione comune.
Nel confronto con i classici si manifesta la perdurante validità dell’ideale platonico, ovvero la necessità di volgere lo sguardo al bene, alla verità, alla giustizia e alla bellezza: non certo per coltivare la retorica delle grandi parole, ma per abituare a osservare tante meschinità quotidiane dalla giusta distanza, e con sana ironia (socratica). Breschi ci ricorda che coltivare un simile atteggiamento è, nella democrazia ateniese del V secolo a.C. come in quella contemporanea, l’unico modo in cui il «meglio di niente» può sopravvivere al baratro del «niente» assoluto.
[in uscita nel IV numero della rivista “Il Pensiero Storico” – www.pensierostorico.com. Si ringrazia il direttore Antonio Messina per la gentile concessione]