È sempre piacevole lettura quando una biografia si presenta come l’altro modo di fare letteratura, prosa e poesia insieme. Alcuni scrittori si rivelano romanzieri e poeti grazie alle biografie che scrivono su “veri” romanzieri e “veri” poeti. Pol Vandromme (1927-2009), un pluripremiato giornalista e scrittore belga francofono, è uno di questi e la biografia che nel 1958 dedicò a Pierre Drieu La Rochelle ne è l’indiscutibile conferma. Va riconosciuto a Luca Gallesi e alla casa editrice OAKS il merito di aver riproposto sul mercato editoriale italiano uno dei miglior viatici alla conoscenza di Drieu, sia come scrittore, sia come uomo. Fine esegesi letteraria e analisi psicologica si amalgamano perfettamente in questa biografia intellettuale uscita per la prima volta in Italia nel 1965 per i tipi di Borla, a cura di Alfredo Cattabiani, che ne firmò anche l’elegante traduzione ed una breve ma illuminante presentazione, entrambe qui opportunamente mantenute.
La biografia su Drieu ha la levità di un racconto di Yasunari Kawabata e il tratto nervoso e sanguigno di certe pagine di Louis-Ferdinand Céline, scrittore e personaggio quanto mai scoppiettante e controverso a cui sempre Vandromme dedicò una biografia nel 1963, altrettanto lucida e affascinante. D’altronde, surrealismo – sia pur molto francese e ben poco nipponico – e realismo si mescolarono nello stile di Drieu, cosicché, come per i due scrittori appena citati, anche nel suo caso possiamo parlare di una modalità insieme visionaria e realistica di trasfigurare un mondo sociale e politico mai del tutto accettato, anzi infine drasticamente rigettato. Di questi tre autori solo Céline si salvò, probabilmente perché il più cinico, come testimonia la stessa sua scrittura, che presenta persino compiaciuti tratti plebei e dunque un’ironia, sovente sconfinante in sarcasmo, che mancò sia a Kawabata sia a Drieu. Il suicidio fu per entrambi l’estrema testimonianza dell’assoluta serietà con cui avevano vissuto ogni cosa da loro emotivamente percepita, razionalmente detta e scritta. Il massimo e inarrivabile esempio in tal senso, come si sa, fu Yukio Mishima.
Drieu «non riuscì mai a sentire intorno a sé la presenza del mondo» (p. 75), come ben arguisce Vandromme, per esuberanza di amore, di cui era dotato in eccesso per saperlo gestire, per potergli trovare adeguata corrispondenza, tale da appagarlo, acquietarlo in modo vitale, senza cioè spegnerlo. Inevitabile, pertanto, che ad ogni slancio euforico seguisse rapidissimo il disgusto e immediatamente la noia lo proiettasse altrove. Braccato dal suo doppio, avrebbe voluto irretirlo, risucchiarlo e digerirlo. Niente da fare, restava sempre estraneo a se stesso. Alienato. Questo accadeva perché la sua overdose d’amore, una dotazione naturale, nativa, era piuttosto simile ad un eccesso di libido, di adolescenziale energia spermatica, che ha naturale, abbondante semenza, ma non sa che farsene, non sa né vuole generare vita che responsabilizza, ma solo erompere per la gioia di sentirsi vibrare e, vibrando, identificarsi. Riappropriarsi di sé. Mi accendo di energia che infiamma le vene, inonda i lombi, e tutta questa sensazione di potenza mi dice che io esisto e che il mondo è mio. Un meccanismo psicologico del genere pare albergare in Drieu sin dalla più tenera età. Un tragico tic da cui non seppe liberarsi nemmeno in età matura. Vandromme lo spiega così, nell’ultima pagina della sua biografia: «Drieu, romanziere delle nostre insoddisfazioni e dei nostri rimorsi, ha trascinato la sua vita nel rimpianto di non essere un eroe e un santo. Per questo si rivela oggi così vicino al cuore dei giovani. Drieu ha sempre scritto per loro. Ha pensato sempre per loro. È morto per mantenere il giuramento, che aveva fatto da adolescente, di essere sempre fedele alla giovinezza» (pp. 149-150).
Pierre Drieu La Rochelle, lo scrittore e l’uomo, è per questo un perfetto esemplare di romantico incastrato nell’epoca del massimo positivismo, perché, checché se ne dica, la guerra ’14-’18 e il ventennio che ne seguì si mossero all’insegna del progresso tecno-scientifico e del macchinismo. Il cosiddetto irrazionalismo politico, che pur vi fu, e cospicuo, nonché foriero di immani tragedie, rappresentò il naturale fronte reattivo e infine perdente. La parte più cospicua e brillante dell’intellighenzia europea fu il lamento dell’impotenza che aveva ancora velleità di reazione vittoriosa e di comando. Contagiò i più. Alcuni se ne discostarono per tempo. Si veda la parabola di Thomas Mann, per fare un esempio. Altri si vaccinarono quasi subito, tramite un lungo silenzio, ma quando infine parlarono la distruzione della ragione non rientrava minimamente nell’orizzonte delle possibili tentazioni a cui cedere. Penso ad un autore come Erich Maria Remarque, ma non fece un clamore paragonabile a quello di un Drieu o di un Céline, ed infatti emigrò oltreoceano. Gli Stati Uniti tornarono ad essere, o si confermarono, come l’anti-Europa. Il Vecchio Continente nell’entre-deux-guerres pullulava di eccelsi e brillanti ingegni in stato di febbrile eccitazione, di selvaggia furia al contempo iconoclasta e progettuale, brutalmente iperattiva e ingegneristicamente costruttrice.
La borghesia, da classe in sé, divenne classe per sé, spogliandosi dei residui di aristocraticismo ancora emulato e simulato per quasi tutto l’Ottocento, andando incontro a braccia aperte a quel democraticismo plebeo che la pura etica borghese, nuda e cruda, non poteva non riconoscere come suo figlio. Piaccia o non piaccia, sta qui il motivo di fondo dell’ossessione di Drieu e di tutti i chierici che, a detta di alcuni, tradirono i principi dell’Illuminismo. Mi riferisco ovviamente a La Trahison des Clercs, celebre testo con cui Julien Benda nel 1927 denunciò pubblicamente la tendenza anti-universalista e anti-democratica diffusissima tra gli intellettuali francesi e tedeschi a favore delle “passioni politiche” come la lotta di classe, il nazionalismo e il razzismo. Benda criticava duramente anzitutto i suoi connazionali Maurice Barrès e Charles Maurras, guarda caso entrambi figure ammirate da Drieu, di riferimento per la sua giovanile formazione culturale.
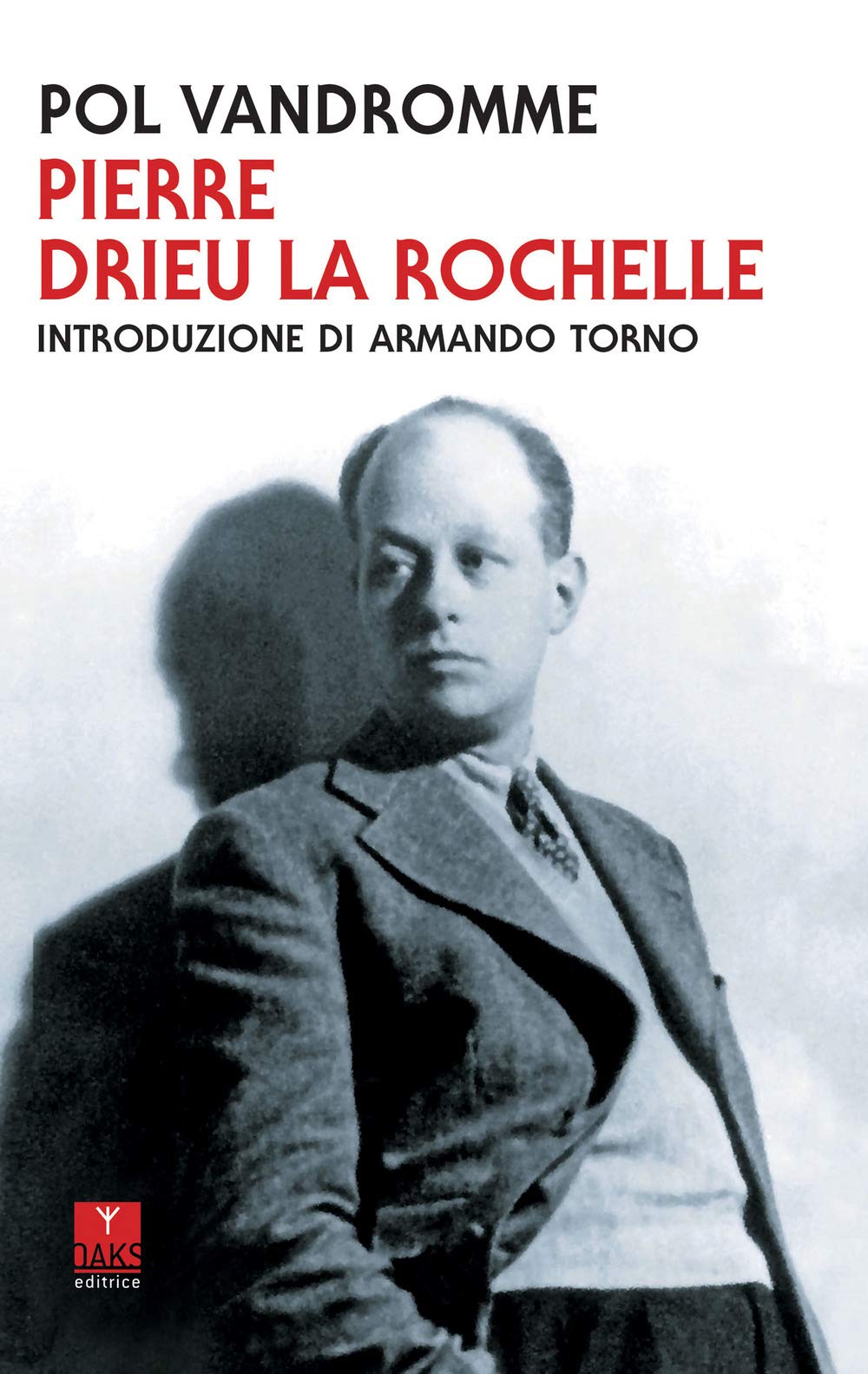
Più in generale, di quasi tutta quella schiera di intellettuali impegnati (l’espressione non sorprenda, poiché l’impegno politico degli uomini di cultura fu prevalentemente “a destra” nella prima metà del Novecento) il dinamitardo filologo-filosofo Friedrich Nietzsche fu il diavolo tentatore ed il profeta ai cui piedi si gettarono inebriati. E non poteva essere che così. Nietzsche intuì per folgorazioni razionali rivestite con formule da mistico, mentre la nutrita e variopinta schiera di intellettuali classe anni Novanta (del diciannovesimo secolo) tradusse la sua previsione. Si trattava solo di essere coerenti e portare alle sue estreme conseguenze l’inevitabile attrito tra due tipi umani e due società inconciliabili. Fu scontro all’ultimo sangue tra un’esangue aristocrazia e una prorompente democrazia. Parliamo di mentalità e costumi, di ruoli e istituzioni. Antropologie e sociologie, le une contro le altre armate. La resa dei conti finale, a lungo procrastinata, fu coerentemente dichiarata. Non poteva essere ulteriormente rinviata.
La vittoria arrise infine alla democrazia. Bene, tutto risolto allora? A distanza di circa un secolo dall’avvio di quell’immenso incendio continentale non pare così pacifico rispondere affermativamente. Qualcosa riemerge, o persiste camuffato, clandestino e sotterraneo. È la stessa avvertenza che il tanto vituperato Francis Fukuyama mise in conclusione del suo troppo inopportunamente citato ma troppo poco seriamente letto e meditato saggio su La fine della storia e l’ultimo uomo (1992). Il desiderio di riconoscimento non è cessato con le società del benessere, a maggior ragione da quando quest’ultimo si è ridotto drasticamente in Occidente, così come si è assottigliato, per diretta conseguenza, lo strato sociale del ceto medio, vero pilastro di quei sistemi rappresentativi fondati sui diritti di libertà individuale e noti col nome di democrazie liberali di massa. Il desiderio di essere riconosciuti può tradursi in megalotimia, se i meccanismi dell’economia sociale di mercato saltano e diventa impossibile favorire piuttosto una isotimia, ossia un mutuo riconoscimento tra tendenzialmente eguali. La libido dominandi è figlia di un riconoscimento negato, compresso. Come il rimosso psichico e i nodi dell’anima, quel desiderio d’improvviso sbalza ed esplode se non lasciato fluire e fisiologicamente risolto, lasciato esprimersi.
Tutte queste riflessioni sono sollevate dal ritratto di uno scrittore, Drieu La Rochelle, che risulta pertanto assai meno inattuale di quanto possa apparire. Ha pertanto ragione Armando Torno, il quale, nell’introduzione a questa nuova edizione italiana del libro di Vandromme, così esordisce: «un giorno, uno dei tanti che ha ancora a disposizione questo secolo, quando si vorrà scrivere la storia della letteratura del Novecento senza concessioni o strizzate d’occhi, evitando i giudizi bigotti oggi chiamati “politicamente corretti” o le esagerazioni di parte, bisognerà fare i conti di nuovo con alcuni autori che sono rimasti in un cono d’ombra per le loro scelte “sbagliate”. Tra essi ci sarà senz’altro Pierre Drieu La Rochelle» (p. I). La collaborazione con i tedeschi durante l’occupazione militare della Francia costò la vita anche al poeta Robert Brasillach, che pagò un po’ per tutti coloro che cedettero, più o meno volontariamente, al nazismo. Personalmente ritengo che le opere di alcuni di loro resteranno come testimonianza di un’epoca, della fascinazione che un paio di generazioni di intelletti raffinati subì per il culto della giovinezza e della volontà di potenza. Soprattutto va compreso quanto la letteratura sia figlia del proprio tempo, anche quando non è affatto effimera e di scarsa qualità, poiché certe pagine di un Drieu o di un Brasillach, per non dire di un Céline o del premio Nobel 1920 Knut Hamsun, altro collaborazionista norvegese filonazista, mantengono un loro valore estetico extrastorico. Quello fu il tempo della prima guerra mondiale, avvenimento di portata non ancora del tutto ben compresa e mai pienamente comprensibile, se non proprio rimuginando gli scritti di tutti questi autori, maledetti perché folgorati da un’esperienza senza precedenti, tanto sovrumana da essere assolutamente disumana. Come reggere psicologicamente a quell’urto bestiale, specialmente quando l’arruolamento era stato volontario e il battesimo di fuoco era stato sognato sin da ragazzo come una pagina da romanzo cavalleresco in salsa tardo-romantica?
Se leggerete il secondo capitolo della biografia di Vandromme, comprenderete non soltanto la psicologia di Drieu, ma anche quella retrostante a moltissima letteratura di guerra, la più genuina e di qualità, valida ancora oggi, artisticamente indiscutibile. Il biografo ci ricorda quanto Drieu fosse «convinto che esiste una vocazione per la guerra, che la guerra è per certi uomini un ordine, quasi un ordine religioso» (p. 59), ma l’esperienza diretta nel fango delle trincee sotto incessanti bombardamenti ha smentito brutalmente queste visioni tra l’ingenuo e il delirante, così che infine egli «ha maledetto la guerra moderna», perché «il mondo industriale ha distrutto l’essenza cavalleresca della guerra» (p. 61). In conclusione, «Drieu non dice di essere contro la guerra perché essa uccide, ma perché uccide senza offrire nessun vantaggio, senza permettere la sfida e il combattimento. Protesta in nome della nobiltà e della cavalleria. Rifiuta la guerra moderna perché essa rende il soldato schiavo, schiavo del numero e delle macchine infernali, perché impedisce agli uomini di essere ancora uomini civili» (p. 63). Insomma, lo scrittore francese «amava solo il combattimento e, quando la guerra non era più lotta leale e diventava o un’attesa snervante o una carneficina, la detestava» (p. 54) e «odiava gli eserciti che somigliavano a un ministero, perché era entrato in guerra come si entra in convento» (p. 57). Più chiari ed esaustivi di così non si può essere.
Questa è la bravura di Vandromme, rapido e ficcante. Fulminante. Come quando sintetizza il capitolo “donne”, centrale nella vita e nella poetica di Drieu, cesellando il seguente giudizio: «L’esperienza erotica non gli è servita che a renderlo consapevole dei propri limiti, della propria incompiutezza» (p. 79). Anche dopo il 1918, eccitato e disgustato, Drieu, il poeta delicato e virile, andò alla guerra, qualunque essa fosse, polemica letteraria oppure scontro politico di piazza, ma sempre e comunque contro se stesso e nient’altro che non fosse quell’ostacolo interiore al suo volersi sentire finalmente uno, non più costantemente sdoppiato, dimidiato. Giustamente Vandromme segnala quanto Drieu sia stato quel poeta, per indole e vocazione mai del tutto accettata, che voleva farsi ben altro, un duce, nel senso antico e romantico di capo condottiero di un manipolo di guerrieri scagliati contro un nemico possibilmente più grande per numero e più forte per potenza, così che la sorte fosse segnata, sigillata e sublimata dalla morte. Ci provò in politica nel 1936, trasferendo nella figura di Jacques Doriot e del suo Parti Populaire Français questi sogni ad occhi aperti. Anche qui l’illusione durò poco più dello spazio d’un mattino.
Serpeggia nella vita e nel pensiero dello scrittore francese un cupio dissolvi, nemmeno troppo celato? La troppa libido non poté che rovesciarsi in destrudo? Un’inevitabile discesa da Eros a Thanatos? L’ho sempre sospettato, sin da quando lessi per la prima volta i suoi romanzi, nonché i diari, bellissimi per quell’educata spudoratezza delle confessioni più intime che contengono, annotate con apparente noncuranza e date in pasto quasi a voler essere sbranati da critici e detrattori. C’è del masochismo in Drieu. Eppure il modo in cui si confessa lascia affascinati. È questione di stile, evidentemente, di come sa usarlo. Il discorso vale anche per la sua saggistica politica o di costume. Scrive Vandromme: «Il valore dei suoi saggi politici è dovuto al fatto che sono opere d’intuizione, scritte di slancio, passionalmente. Sembra, leggendoli, di assistere alla nascita di un pensiero. Ecco perché ci paiono spontanei, inattesi, burrascosi. Qualcosa nasce davanti a noi mentre leggiamo. Il merito maggiore di Drieu è di mostrarci i primi passi del lavoro intellettuale, i suoi brancolamenti, le sue esitazioni» (pp. 121-122). Con il che condivido anche questo giudizio di Vandromme, che trovo riassuntivo e conclusivo: «Ci sono due modi per entrare nella storia letteraria: o comporre un’opera compiuta, oppure essere il testimone più significativo e rappresentativo di un’epoca. […] Drieu ha scelto la seconda strada, ed è riuscito nel suo intento» (p. 97).

[articolo originariamente apparso su «Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee», 13 marzo 2021]