Il tempo, questo sconosciuto che ci sta addosso come una condanna a morte irrevocabile ma senza data ancora fissata. Il tempo è un concetto utile, che serve all’organizzazione dell’esperienza quotidiana di questo mondo che noi umani abitiamo. Non è però un concetto fondamentale, questo ci dice la fisica quantistica. Alto e basso sono concetti altrettanto utili, ma a nulla servono quando usciamo dalla nostra quotidianità. Questo ci dice Carlo Rovelli, fisico teorico che studia la gravità quantistica ed è ormai noto al più largo pubblico grazie ad alcuni splendidi testi di alta divulgazione scientifica. L’aristocratica Adelphi ne ha fatto una pop star, in qualche misura. Qui mi riferisco soprattutto al suo denso libretto L’ordine del tempo, da cui traggo alcuni passaggi conclusivi, che non lasciano indifferenti:
Io non vorrei vivere come se fossi immortale. La paura della morte mi sembra un errore dell’evoluzione: molti animali hanno un’istintiva reazione di terrore e fuga se si avvicina un predatore. È reazione sana, permette loro di scampare pericoli. Ma è un terrore che dura un attimo, non qualcosa che permane. La stessa selezione ha generato questi scimmioni spelacchiati con lobi frontali ipertrofici dall’esagerata capacità di prevedere il futuro. Prerogativa che certo aiuta, ma che ha messo noi scimmioni davanti alla visione della morte inevitabile; e questa accende l’istinto di terrore e fuga dai predatori. Insomma, penso che la paura della morte sia un’accidentale e sciocca interferenza fra due pressioni evolutive indipendenti, un prodotto di cattive connessioni automatiche nel nostro cervello, non qualcosa che per noi abbia utilità o senso.
Si parla della morte come il senza-senso e, addirittura, il sommamente inutile. La morte come dolce e quasi francescana «sorella del sonno». Rovelli subito dopo precisa e spiega che questa è la lettura razionale, che non fa i conti con il fatto che «quello che ci motiva non sono argomenti razionali» e che noi «non siamo in primo luogo esseri ragionevoli», semmai spinti anzitutto dai bisogni, dagli affetti, dalla sete di vivere. Al più, la ragione è un arbitro tra gli istinti. Pagine vergate con forza, queste di Rovelli, da cui prorompe pensiero pugnace e tenace, fermamente convinto. Subito ha risvegliato in me alcuni interrogativi sul rapporto tra fisica e filosofia. Al perché la prima sarà forse oggi più amica della Verità, ma la seconda spinge ad una stretta di mano non solo con Platone, ma con tanti altri esseri viventi in carne ed ossa. Esseri quotidiani, che vivono il giorno, conficcati nel tempo pensato e soprattutto vissuto come scansione rettilinea, scala mobile o freccia scagliata che possiamo solo illuderci di frenare. Un moto verso un dove che resta ignoto e per questo ci inquieta. Su questo rullo semovente noi siamo sostanzialmente passeggeri. Più che piloti, possiamo farci paracadutisti o disertori che preferiscono un folle volo, a precipizio, comunque e sempre. Icaro è nostro fratello. Fatti fummo ad esser guidati, non guide.
Per uscire dalla nostra quotidianità e scoprire, ad esempio, la realtà fuori dalla gravità, dobbiamo farci astronauti. Privilegio per pochissimi eletti, anche se ci si addestra una vita intera. Non è detto ti assegnino ad una delle rarissime e costosissime missioni spaziali. Meno raro diventare uno studioso di fisica, un appassionato di scienza, che, come afferma sempre Rovelli, può così scoprire che la nostra immagine del mondo è molto spesso sbagliata, è limitata, vale solamente nel suo ambito, comunque ristretto. Noi rivendichiamo dimensioni “a misura d’uomo”, ma è assai poca cosa per una approssimazione al Vero che sia almeno minimamente soddisfacente. La Verità, dunque. Con l’iniziale maiuscola. La fisica teorica non la nega. Anzi. Pare esserne più assetata della stessa teologia, almeno di quella sistematica, o dogmatica, per cui la verità è già data, ab origine e ad infinitum. È Rivelazione e il contenuto di verità è proclamato e preservato dallo studio, teologico appunto. In fisica è scoperta, sì, di qualcosa che da sempre è, ma non è come i nostri sensi ci suggeriscono le cose siano. Certe realtà, che sono perché sono, nemmeno riescono ad essere percepite. Con la fisica quantistica, infatti, ci gettiamo a capofitto nell’infinitamente grande, ma soprattutto nell’infinitamente piccolo, sino a poco tempo fa assai poco esplorato e interrogato a dovere.
Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984, diceva: “La bellezza della natura vista dall’interno e nei suoi termini più essenziali, è ancora più perfetta di quanto appaia esternamente. […] Mi sento onorato di poter vedere queste cose, fortunato, perché la natura è effettivamente uno spettacolo che non si esaurisce mai”. Dunque la scienza è qui intesa, al pari della filosofia, come desiderio di sapere innescato dallo stupore per la physis. La fisica nasce dalla meraviglia? Platone ed Aristotele stringono le mani a Newton ed Einstein. No. Emanuele Severino dice no, non proprio. Lo thaûma (dal greco θαῦμα) non va tradotto in senso debole e tenue come “meraviglia”, stupore”, bensì come “trauma”, “terrore”, “angosciante turbamento” che ci agghiaccia e paralizza di fronte alla natura e alle sue inspiegabili opere. La scossa fatale giunge dalla terrificante scoperta che ogni cosa nasce e muore. È dunque in divenire. La proiezione in avanti è pensabile. Proprio questa sua pensabilità all’interno della nostra mente, la facoltà di prefigurarci il futuro fa di noi animali speciali. A proposito di futuro c’è un problema enorme, immenso: sappiamo prefigurarlo come avvertimento, monito, congettura, ma non riusciamo a dargli una forma definita, certa, inequivocabile. Non lo possediamo, il futuro. Eppure lo abbiamo creato noi, lo sentiamo come certezza. Una certezza ingovernabile, però; non gestibile, se non apparentemente. Diventare signori del futuro, questa l’ambizione dell’uomo a mano a mano che si è fatto più moderno. La fisica quantistica pare rendere ai nostri occhi ancor più sconcertante e sconfortante la natura, una volta indagata. Ce ne sentiamo per lo più alienati e sgomenti. Affascinati, solo se filosofi, nel senso letterale di amanti della ricerca della verità.
Severino ricorda come possa esservi anche quel «fenomeno derivato per il quale il filosofo, magari protetto da una fittizia tranquillità, “si meraviglia” di ciò che per l’uomo comune è qualcosa di ovvio». Da lì s’innesca la scienza come ricerca e scoperta che le cose funzionano in modo ben diverso da come l’evidenza apparentemente insegna, in realtà fuorvia. La filosofia, aggiunge il filosofo bresciano, «nasce perché il modo in cui il mito tenta di proteggere l’uomo fallisce». Altrove scrive che «la filosofia intende infatti indicare il vero Senso del mondo, al quale, dunque, nulla può sfuggire (“Come è possibile sfuggire a ciò che non tramonta?”, dice Eraclito), e quindi prevede l’essenza di tutto ciò che può accadere». Il problema di fondo è che la realtà è in sé inospitale, Leopardi ce lo ha ribadito nella forma più alta raggiunta dalla nostra lingua dai tempi di Dante. Eppure non impariamo quasi nulla, anche se a scuola per fortuna ancora lo si insegna. Spesso si parla più del verso che del pensiero del poeta recanatese. Senza il secondo, però, il primo stona.
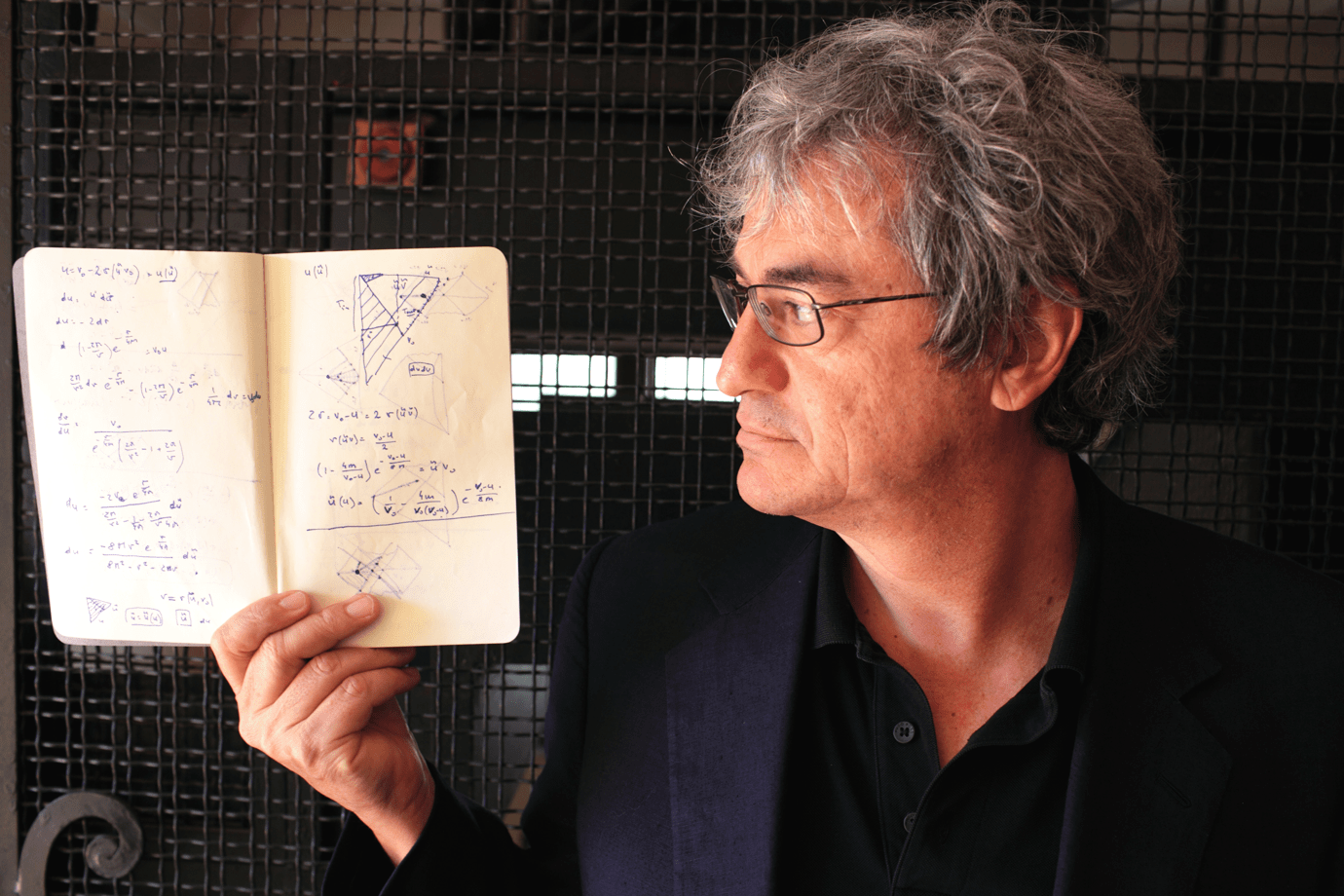
Rovelli scrive: «Avere paura del passaggio, avere paura della morte, è come avere paura della realtà, avere paura del sole: perché mai?». Perché ci rivela quel che siamo, almeno in apparenza, nei limiti di quanto percepito tramite i cinque sensi. Allora pensiamo, filosofiamo, come Severino ci suggerisce, per rispondere all’orrendo, al tremendo che la Natura ci squaderna davanti agli occhi e ci conficca nella carne. Così la via della filosofia continuerà ad essere percorsa da tutti coloro che cercheranno una protezione. Rovelli pare ammonirci nei seguenti termini: solo chi vince la paura sarà davvero libero e scoprirà la bellezza del mondo, avvicinandosi un po’ di più al suo segreto. Ma, in fondo, non è insegnamento che già troviamo nel Vangelo secondo Matteo (Mt 7,21-27)?
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l’anima e il corpo.
Chi crede non ha paura di nulla, nemmeno della morte. Così il cristianesimo insegna. Così, ed è ciò che apprendiamo da Kierkegaard, riusciamo a sconfiggere il male supremo, la malattia mortale che è, più precisamente, la disperazione generata dal pensiero della morte. Traduzione più corretta, infatti, dell’opera del filosofo danese pubblicata nel 1849 è: La malattia per la morte. Mi dispero, mi divoro d’angoscia, perché ignoro la mia vera destinazione, da sempre già assegnata, da sempre già consegnata, ossia l’eternità mia e di tutti nel Padre a maggior Gloria di Dio.
Chi dà la forza a Rovelli di dirsi assolutamente certo che rispetto alla morte egli non nutre alcuna paura? E se non lo ha della propria, che ne è di chi gli è più caro? È prevedibile il quantum di sofferenza per simili lutti? Anche prevedendolo, siamo indiscutibilmente sicuri che sapremo sostenerla? Da cosa nasce l’assoluta persuasione che resteremo sempre sereni d’animo e irremovibili da passioni come stiliti nel deserto? Queste domande, forse per lui già evase ed archiviate, restano per il maggior numero dei mortali tanti colpi, incessanti e martellanti come fotoni, che si spostano alla velocità della luce, mai fermi rispetto a qualsiasi osservatore, dal raggio d’azione illimitato. C’è un punto che non mi convince nel suo libro L’ordine del tempo, entusiasmante come molti altri suoi scritti: là dove afferma che «quello che ci porta non è la riflessione sulla vita: è la vita». La vita è umana perché è un vivere riflesso e riflettente, generato e generante, sull’esterno come sull’interno, rispetto al corpo che siamo, o che portiamo. Siamo vita che riflette e genera nel mentre vive. Di qui una sommaria e precaria conclusione.
Dal dialogo che ho immaginato tra il fisico e il filosofo apprendo due lezioni. La prima: se, come leggiamo nel Teeteto di Platone o nel libro primo della Metafisica di Aristotele, la filosofia nasce dalla meraviglia di fronte al manifestarsi della natura, mi pare che la fisica teorica contemporanea, secondo quanto Rovelli magistralmente ci illustra, è forma di sapere ancor più stupefacente ed appagante. Approssima meglio un vero, percuotendoci in ogni nostra più salda convinzione, per cui vacilliamo, ma, se in noi alberga una genuina curiositas, restiamo affascinati e inebriati da un mondo vero che sta dietro il mondo apparente. Con il che, per inciso, Platone si vendica di Nietzsche, che resta in lacrime aggrappato al cavallo fustigato. A questo primo apprendimento aggiungo una considerazione. Aristotele non si limita a dire che la filosofia è scienza dei «principi primi e delle cause», ma precisa che «anche il bene e il fine delle cose è una causa». A che fine? A fin di bene? Di questo la fisica non si chiede. Eppure la domanda sorge tanto spontanea quanto impellente. Come mai? Possiamo sopprimerla con un dito premuto sulle labbra? Cancellarlo con un tratto di penna? Se lo facessimo, credo che otterremmo solo un incremento di coscienza filosofica e un sovrappopolarsi di aspiranti filosofi, agguerritissimi.
Resta la seconda lezione che ho appreso dal breve dialogo immaginato. Se, come leggiamo nel Fedone di Platone oppure negli scritti di Seneca, la filosofia è esercizio a morire o quantomeno praemeditatio malorum, mi pare che la fisica contemporanea non regga fino in fondo il confronto. Non lo regge se scomodiamo appunto l’approdo cui giunse Severino. In un dialogo pubblico tenutosi a Padova nel 2009, confrontandosi con il cardinale Angelo Scola, il filosofo bresciano sentenziò: «Non appare l’annientamento, ma la volontà che le cose si annientino». Immane stupore. Come se non bastasse, aggiunse: «L’esperienza non mostra l’annientamento, sì che il pessimismo che unisce ragione e fede, e fedi dell’Occidente, altera ciò che si mostra e impedisce il pensiero essenziale del ritorno concreto dei morti, di tutti i morti (e anche intorno al “dove” essi ritornino […] è la conseguenza necessaria della comprensione autentica di ciò che si mostra, di ciò che appare)». Pertanto, conclude Severino scioccando, «il concetto cristiano di resurrezione è tra i più criticati, ma è anche una grande metafora dell’incontrovertibile». Una metafora, e perciò uno sviamento, ma anche un’allusione all’eternità di ogni essente.
Finché l’uomo cercherà protezione, ed è facile previsione che ciò prosegua per la stragrande maggioranza di noi ancora a lungo, molto a lungo, la filosofia avrà una risposta in più. Forse di sola consolazione, come per Boezio. Si veda la radice latina della parola, cosicché risulterà meno banale di quanto si pensi. Se prendiamo l’espressione solari famen, ovvero soddisfare la fame, il sollievo del consolare è sinonimo di disagio con-diviso, spezzato e spartito tra due o più persone in intima unione. La filosofia come pratica di comunione e liberazione dal male dell’apparente, dalla falsità del diveniente come annientamento. Meno veridica, più terapeutica, la filosofia si mostrerebbe più portatile della fisica, almeno per l’uomo comune. La quantistica si addice forse allo Übermensch, il superuomo, che, anche nell’accezione vattimiana di “oltreuomo”, è però qualcosa di elitario, difficilmente praticabile o persino sconsigliabile.
Un sospetto, infine, si è insinuato tra le pagine di Rovelli: non sarà mica che dalla fisica quantistica possa spuntar fuori un giorno la teoria, ovviamente falsificabile altrimenti non scientifica, che siamo immersi nell’eternità e il divenire, siccome il tempo è un’impressione, è solo un’illusione, una falsa evidenza? In tal caso Severino avrebbe ragione. Ci ha lasciato esattamente un anno fa. Riposa in pace, che la terra ti sarà sempre più lieve.

[articolo originariamente pubblicato su «L’intellettuale Dissidente. Rivista di agitazione culturale», 17 gennaio 2020. Si ringrazia Davide Brullo]