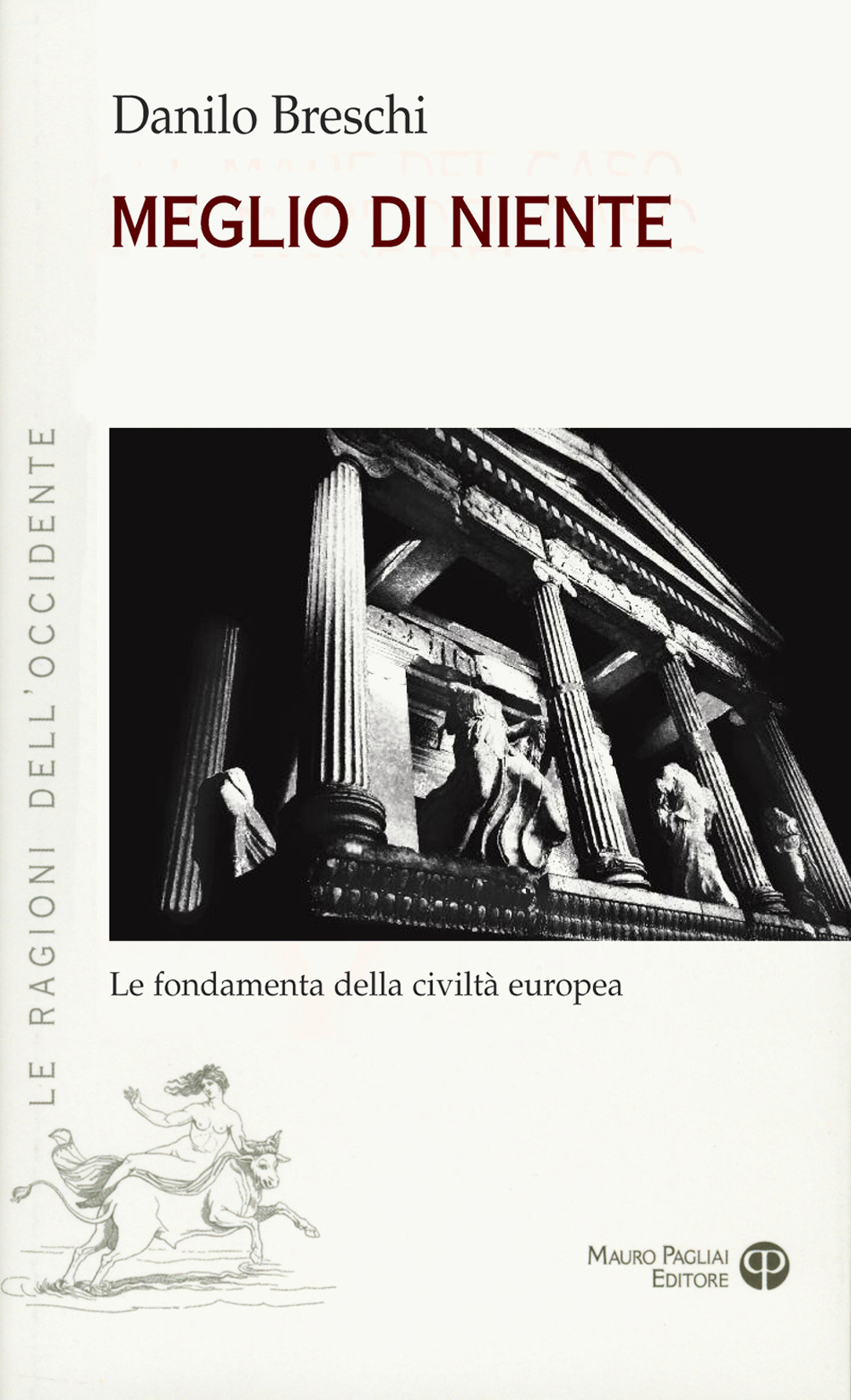Intervista a cura di Alessandra Stoppa
(“TRACCE”, n. 9, ottobre 2018, pp. 22-27)
«La modernità è la realtà. Bisogna rendersene conto e capire come ci sfida». Lo storico Danilo Breschi racconta la paura che chiude, l’eccesso di norme per trovare protezione, la crisi antropologica… Appunti per un cammino anti-utopico, tra libertà, epica e presenza cristiana.
«Come potremmo avere uomini amanti della libertà, che ne sentano la mancanza più del cibo?». Se lo chiede lo storico pistoiese Danilo Breschi, davanti alle caratteristiche del nostro tempo, che lui tratteggia così: «Il rischio della tribù, la paura che chiude, l’eccesso di norme che insterilisce le relazioni e porta alla richiesta di protezione, di rifugio». Laico e allergico a ogni forma di nichilismo, soprattutto quello «gaio, compiaciuto e pieno di senso di auto-colpevolizzazione», Breschi è professore associato di Storia delle dottrine politiche ed autore del recente Meglio di niente, scritto per rispondere a chi preferisce il nulla all’imperfezione e dedicato ai «quattro pilastri di ogni civiltà»: politica, storia, educazione e religione. Un testo che nella dialettica feconda tra valori pagani e cristianesimo, tocca ferite e orizzonti del nostro Paese, i diritti, gli immigrati, il Mezzogiorno, la tecnologia, la mafia, la pornografia. E il nemico numero uno: il deficit educativo. «Prima di tutto va rilanciata la cultura come educazione», come ha scritto sul Corriere della Sera. Lui, che ama la storia perché in essa «si trova l’uomo più che altrove», è convinto che per diradare il nichilismo quotidiano non si debba edulcorare la realtà. Ma, anzi: fermarsi a leggerla, comprenderla a fondo.
Professore, cosa sta capendo dell’oggi? Lei parla, appunto, di «rischio della tribù, stanchezza morale, smarrimento delle convinzioni e indebolimento delle istituzioni»… Per niente un quadro positivo.
Tra i tratti di fondo mi pare ci sia anzitutto l’aver smarrito il senso della misura, in nome di un edonismo diffuso, a buon mercato. Credo che questa perdita del limite sia figlia di un processo di individualizzazione estrema.
L’individualismo come riconoscimento dell’irriducibilità di ciascuno di noi è una cosa, tutt’altra è spezzare ogni legame. I rapporti non sono ricostruibili o sostituibili da norme astratte, che in qualche modo ci costringano a relazionarti: invece oggi accade proprio questo, l’eccesso di norme insterilisce le relazioni vere. Stiamo parlando, certo, di un processo a più livelli e plurisecolare, ma su cui negli ultimi cento anni – e con accelerazioni pazzesche negli ultimi decenni – è intervenuta l’innovazione tecnologica, un fenomeno dissolvente di per sé. Io non sono un critico della modernità. La modernità è la realtà. Ma noi dovremmo avere il senso di essa e di come ci sfida. Esserne all’altezza. Saperla governare.
In che senso governarla?
Nel senso di sottoporla a delle esigenze prettamente umane. Non siamo più, ormai da tempo, all’altezza dell’azione corrosiva che la modernità inevitabilmente porta con sé, con quella forza ulteriore che produce la scienza applicata: la tecnica, che della modernità è una componente imprescindibile.
E come ci sfida questa realtà?
La prima sfida è il deterioramento antropologico, che si esprime in particolare in uno squilibrio crescente tra diritti e doveri. Noterà, ad esempio, come anche da parte di culture che hanno sempre dato la priorità al tema dei diritti ora si sottolinei l’importanza dei doveri. Non per soffocare i diritti, ma perché l’inflazione di quelli individuali va a scapito della crescita o del mantenimento di quelli collettivi. Al fondo, c’è una visione della libertà che è stata svincolata dalla responsabilità, per cui qualsiasi dovere è percepito come negativo, come impedimento. Ad ogni modo, non si può dare la colpa alla modernità, assumendo un atteggiamento arrendevole. Bisogna rispondere. E la risposta è l’educazione. In generale, c’è un deficit educativo per una libertà matura, virile.
Di che libertà parla? Perché oggi, che è il tempo della libertà, è come se di essa si avesse paura?
La libertà di cui manchiamo non è quella diffusa oggi. Come dice Goethe: «Vivere a proprio gusto è da plebeo; l’animo nobile aspira sempre ad un ordine». Oggi predomina questo «vivere a proprio gusto», ma è una libertà mutilata, amputata. È la sottolineatura che fa Dostoevskij nel Grande Inquisitore: all’uomo è stata data la libertà, ma non la sa sostenere. Cristo ha dato libertà agli uomini perché diventassero veramente umani: li ha liberati dall’idolatria, li ha chiamati ad un lavorìo, ad un travaglio interiore. Ciascuno di noi è chiamato a questo. E il compito educativo è cercare che l’altro diventi pienamente libero, quindi anche capace di sacrificio, sopportazione, capacità di fronteggiare il dolore e non cedere alla prima difficoltà. Forse, in questo senso, c’è tanta ipocrisia anche dietro a certi grandi temi, come il divorzio o l’aborto, perché sono “problemi” e ce ne si “libera”. Ma in Università, nelle scuole, vedo l’anelito presente nei giovani e che andrebbe ascoltato: per la complessità crescente della realtà in cui viviamo, sempre più affollata, la libertà è anche desiderare un esercizio autonomo della propria ragione. Se tu distruggi ogni autorità e al contempo non educhi a una libertà vera, tutto finisce nell’eteronomia.
Lei sostiene che un altro tratto dominante oggi sia proprio questo «desiderio di eteronomia». È una sorta di alienazione dalla propria ragione e libertà?
È il bisogno di essere guidati da “fuori” e nasce, soprattutto, dalla normativizzazione dei legami di cui parlavamo prima: «Tu devi accordarti con lui, se no ti sanziono». È una deriva che porta a richiedere protezione, rifugio. Un ritorno al paternalismo, al patriarcalismo, nella sua forma più nuda e cruda.
Diceva che questa tendenza alla eteronomia è legata anche alla distruzione dell’autorità…
Dagli anni Sessanta, tutte le società occidentali sono state investite da una ondata “senza se e senza ma” di delegittimazione di ogni principio di autorità, derubricato a fattore negativo, oppressivo. Questa perdita di riconoscimento di tutto ciò che sta “sopra” – che dura nel tempo, che è in una posizione superiore, chiamato a guidare – ha un effetto domino: crollano il padre, la madre, gli insegnanti, le istituzioni… Le cause, indubbiamente, sono storiche e molto precise: dopo le due Guerre mondiali la società è stata condannata senza appello, per un senso di colpa giustificato, ma gonfiato a dismisura. Il bambino della civilizzazione europea è stato buttato con l’acqua sporca delle derive belliche novecentesche. Oggi siamo sovraccarichi di una narrazione di quello che siamo stati – come italiani, europei, occidentali – eccessivamente negativa: un fardello di cui liberarsi. Questo porta a fuggire il passato per un eterno presente. Ma così si smarrisce tanto, innanzitutto il senso della storia. Ora quello che viviamo ne è in qualche modo l’esito finale: il cosiddetto novitismo, nuovismo, la rincorsa a tutto ciò che è nuovo. Credo che la storia e la storiografia dovrebbero essere recuperate nelle scuole e anche in realtà educative come il vostro movimento: come il senso religioso, che permette di non ridurre l’uomo alla sua biologia, così il senso storico, se diffuso il più possibile, può migliorare la società. Fa ponderare il presente, aiuta a mitigare il giudizio sul proprio tempo e sugli altri, a riconquistare fiducia nell’altro, in sé, nella realtà, che è il punto di partenza per costruire.
Lei ha scritto di vedere nell’educazione delle «sacche di resistenza»: quali?
Io non sono un laudator temporis acti, sono per un cammino anti-utopico: non c’è un “altrove” dove andare a costruire, né avanti né indietro nel tempo. Si costruisce con quello che c’è. Concretamente, senza fare voli pindarici, vedo oasi di libertà per esempio nelle scuole, che non sono malmesse come i media fanno sembrare. Penso ad alcuni insegnanti, a molti insegnanti, in tutti gli ordini e gradi, che credono nella materia umana. E i ragazzi sono meravigliosi. Se tu li guardi negli occhi loro vogliono certe cose, che poi sono sempre le stesse, tra cui anche quelle più delegittimate: ad esempio, che padre e madre siano principi di autorità, ovviamente consapevole, non ottusa e quindi autoritaria… È poco o tanto? Non lo so, ma bisognerebbe raccontare di più il lavoro che insegnanti, realtà educative e associazioni fanno.
E cosa vede insegnando?
In aula è sempre la stessa cosa, ma non è mai la stessa cosa. È l’affermazione di Hannah Arendt: «La scuola deve essere conservatrice per preservare quanto c’è di rivoluzionario e di nuovo in ogni bambino». In questo senso vedo l’eccesso di innovatismo o sperimentalismo, e non si capisce che la novità è sempre nelle persone. E vedo anche un grande bisogno di epica. La figura dell’“eroe”, di cui abbiamo tanti esempi intorno a noi, non è da caricaturare, perché incarna una serie di attitudini psicologiche e di comportamento, chiamiamoli valori – coraggio, sincerità, lealtà, fedeltà, onore e spirito di sacrificio, dominio delle proprie pulsioni, conoscenza del bene e del male –, che rappresentano l’etica cavalleresca, la quale ha tantissimo di quella cristiana. Il mondo non si rovescia, il male non scompare: c’è il male, dentro di noi, ma va fronteggiato. Credo che un ritorno all’epica avrebbe grande valore politico. Tutto ha una ricaduta e una potenzialità politiche: se tu inizi a rapportarti in modo diverso nei confronti dell’altro, hai un effetto politico, per la concezione dell’uomo che porti. Oggi c’è in ballo questo. Ed ognuno collabora a questo.
Ma qual è la differenza tra questa epica, fatta di etica cavalleresca e valori pagani, e il cristianesimo?
Credo si possano vivere elementi di etica cristiana senza avere fede nel Dio neotestamentario. Penso a Cicerone, a Seneca, a un certo riconoscimento del valore dell’uomo. Ma non sarà mai la stessa cosa. Non potrà mai essere la stessa cosa.
Perché?
Ci sono elementi del contesto a-cristiano o pre-cristiano simili, ma che non hanno fatto “società”. Il cristianesimo ha fatto società. Poi, personalmente, credo ci sia qualcosa di più. Forse mi sbaglio, ma penso che un uomo che crede, che sente veramente la presenza di Dio, non si senta mai abbandonato. Se guardo ai cristiani ferventi, nel senso più positivo del termine, vedo che sono un aiuto in senso anti-individualista…
Cosa vede?
Un afflato comunitario, un desiderio di rinsaldare il legame sociale che oggi è debolissimo, quasi nullo. Per esempio, a partire dal rispetto dell’altro: solo se c’è il riconoscimento, c’è anche l’incontro. E poi il vostro contributo a recuperare una dimensione – che deve persistere in un mondo in cui tutto si virtualizza – di relazione diretta, vera, nutrita anche di sentimenti, per quanto sia frainteso questo termine, di sensazioni vere, e che sempre chiede un rapporto di corpi: uno di fronte all’altro. In sostanza, la presenza dei cristiani ridà fiducia nell’uomo in mezzo a una dilagante sfiducia umana. Da storico dico che c’è il dato inconfutabile, costitutivo, del depositato della cristianità: ha forgiato l’Europa. Ma la presenza cristiana deve continuamente testimoniare se stessa. Sarebbe un danno per tutti se venisse meno o fosse meno convinta di sé. I cristiani non sono un aiuto alla società quando, in qualche modo, non marcano una differenza nel loro modo di essere rispetto alle cose dominanti. Conosco persone, anche giovani, dalla robusta fede che sono una presenza chiara, aperta, consapevole, non vergognosa di sé. È così che comunicano il superamento della condizione umana rispetto alla mera orizzontalità.
Il senso del trascendente?
Sì, la verticalità. L’idea che il mondo non finisce con noi, non finisce con me stesso, nome e cognome, non finisce nemmeno coi soli miei cari. Questo aiuta anche a ricostituire il rapporto intergenerazionale oggi perduto. Direi quasi che il fatto che ci sia qualcosa che ci trascende bisognerebbe imporselo, se no arriviamo a un eccesso tale che ci neghiamo, ci mangiamo, ci snaturiamo. È importante che i cristiani si distinguano, essendo quello che sono sempre stati e che sono.